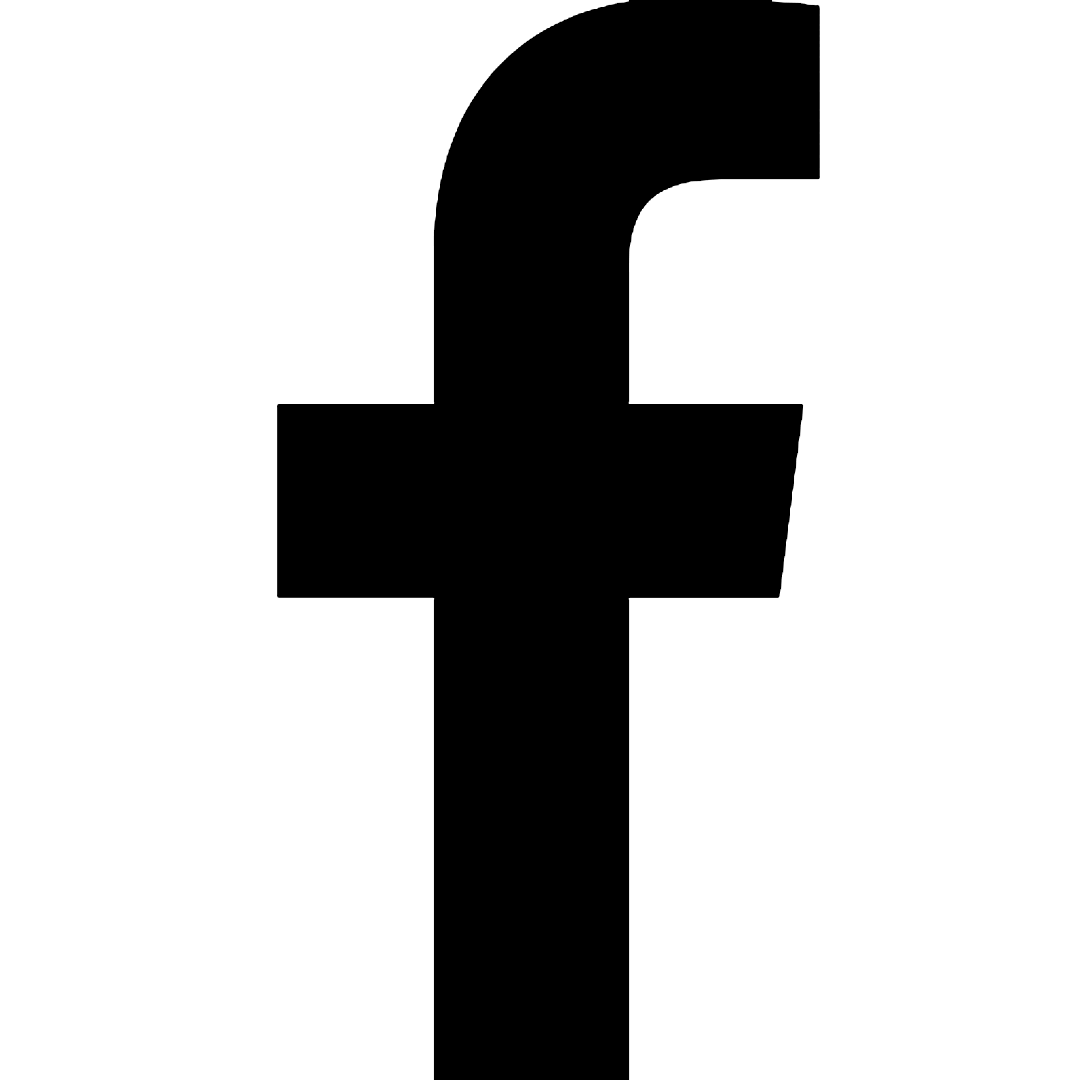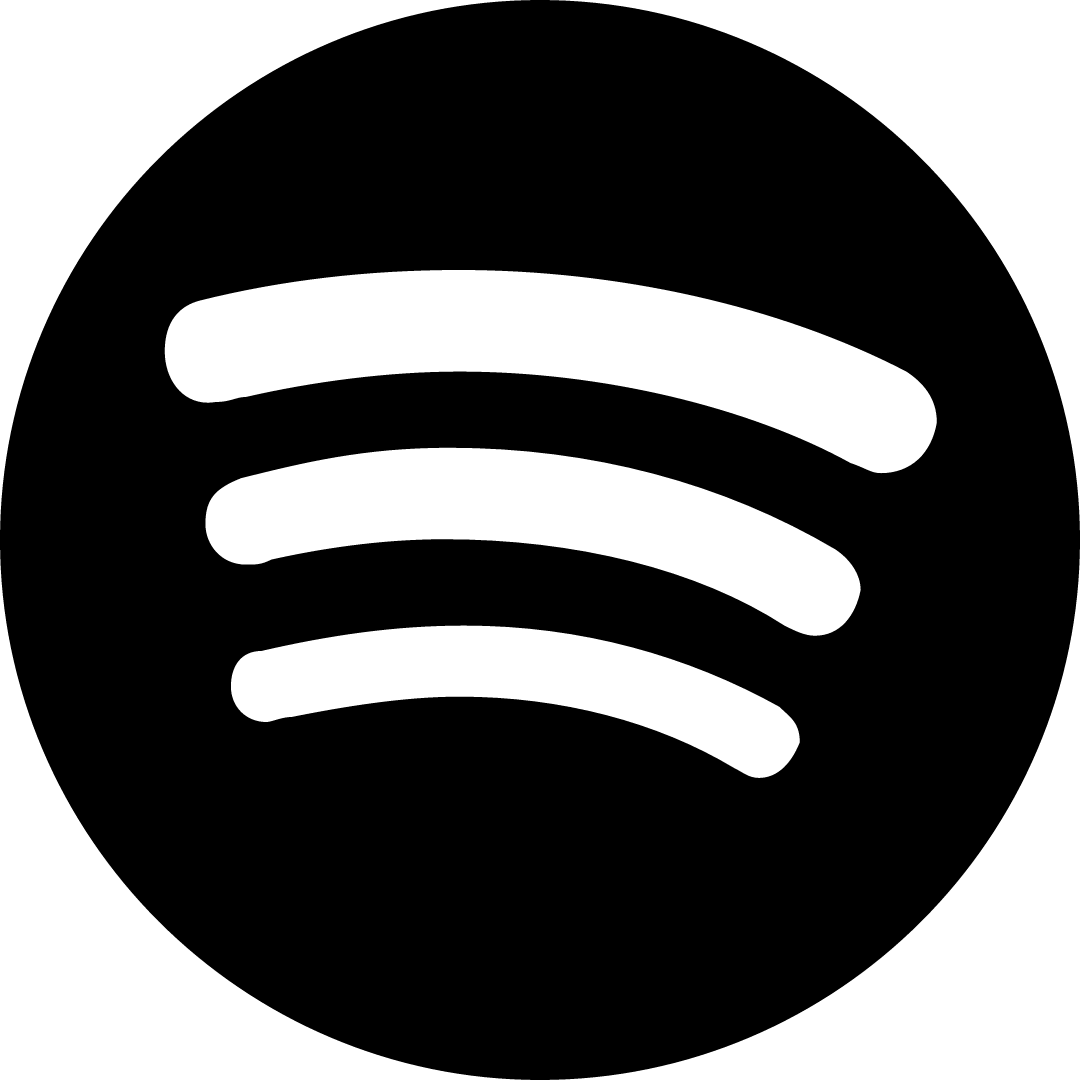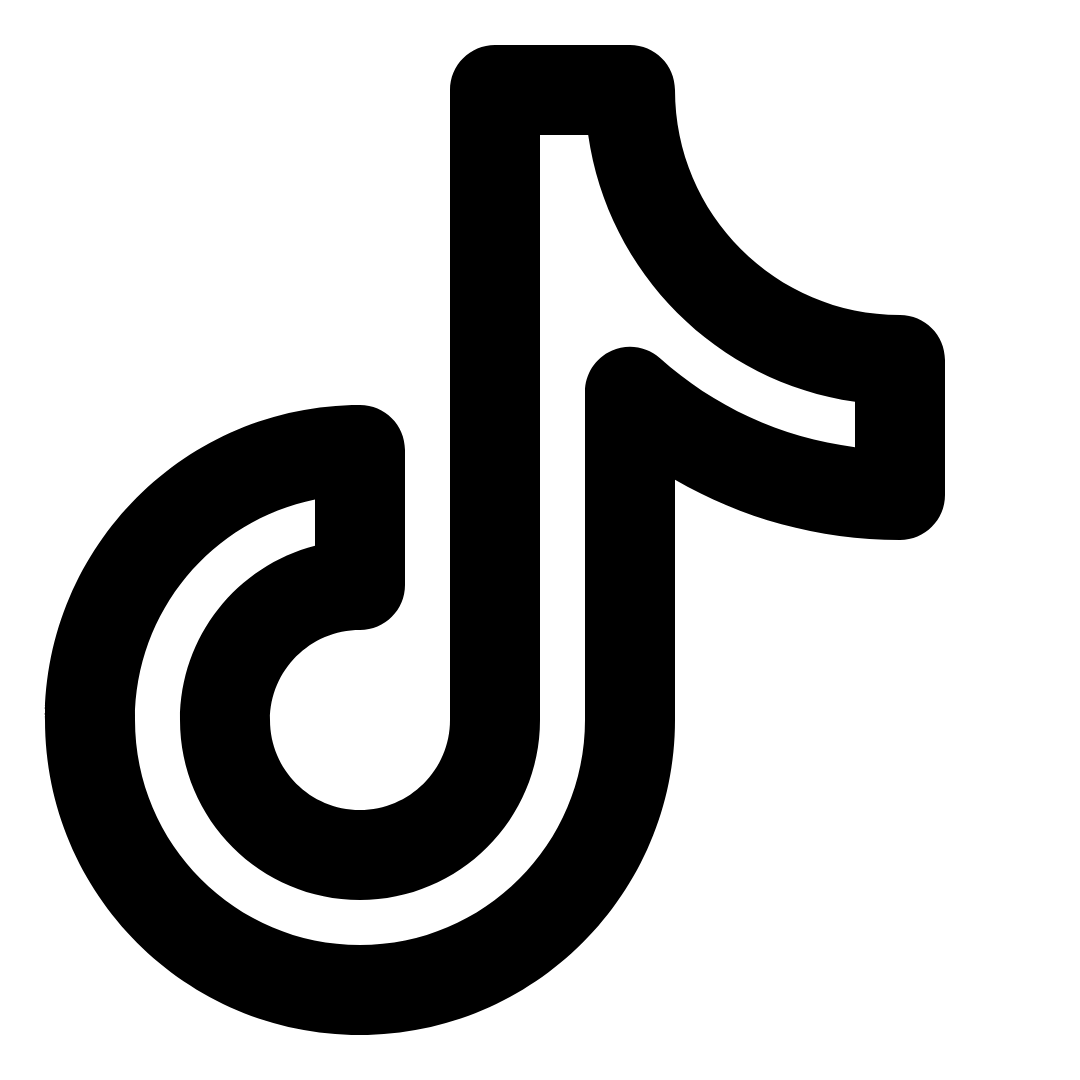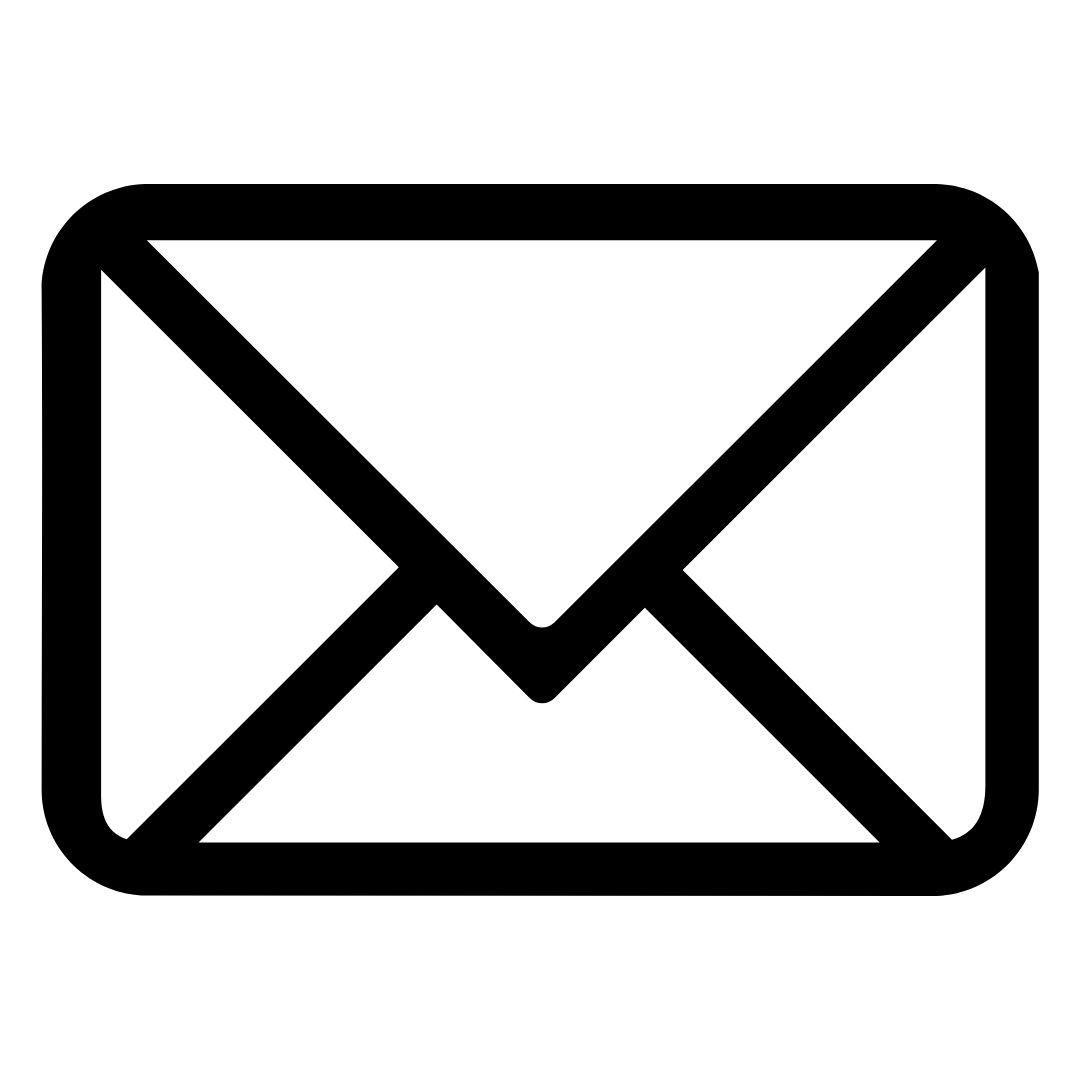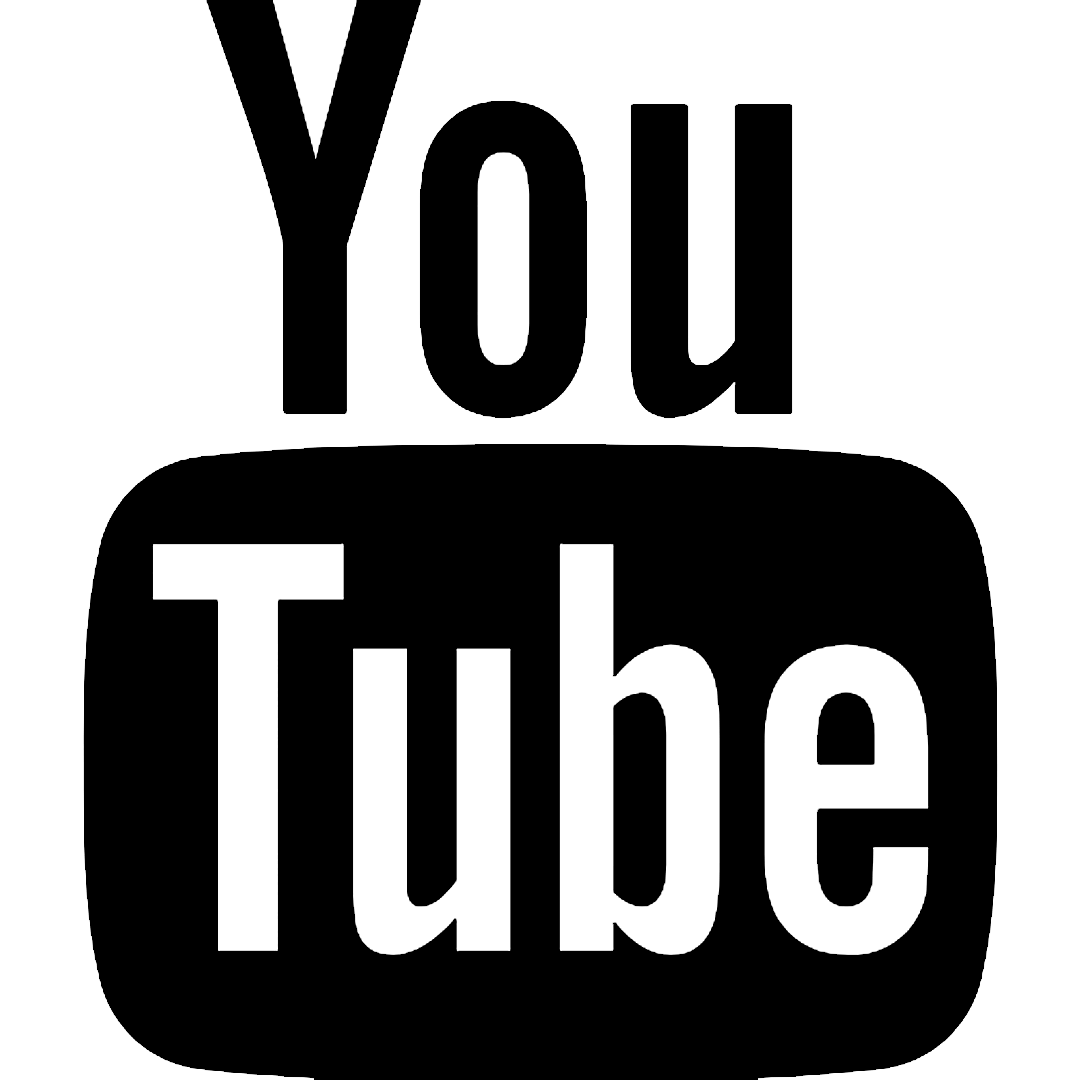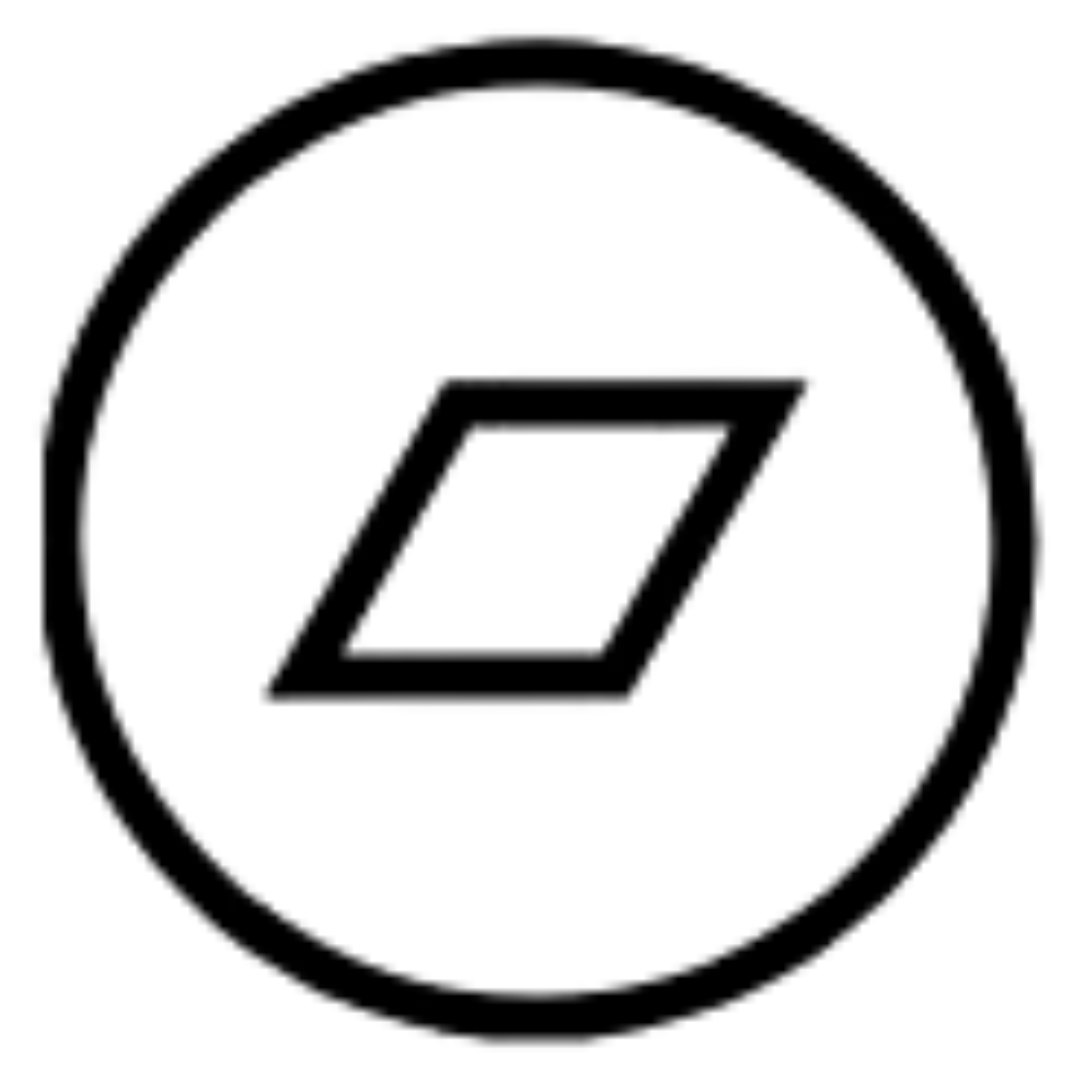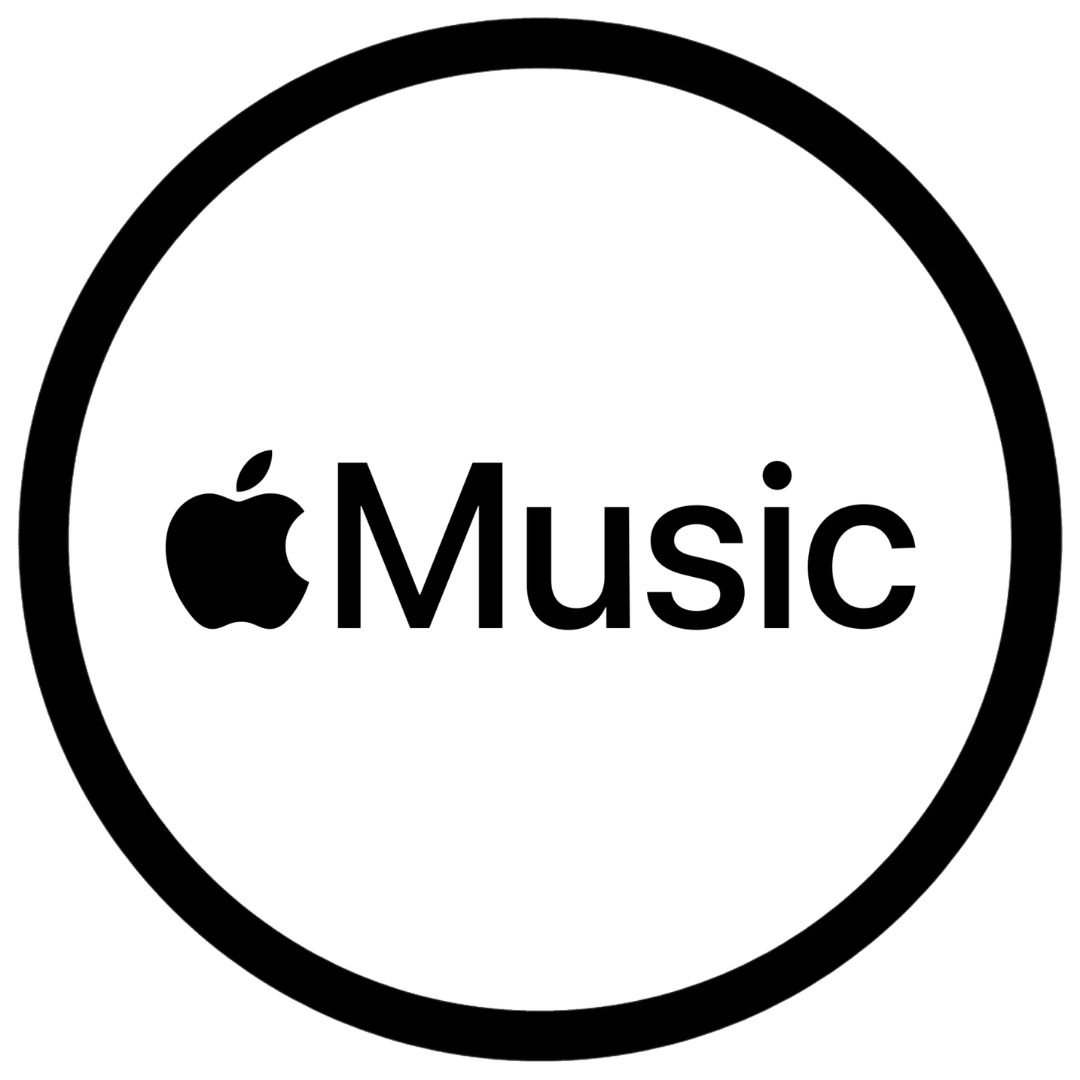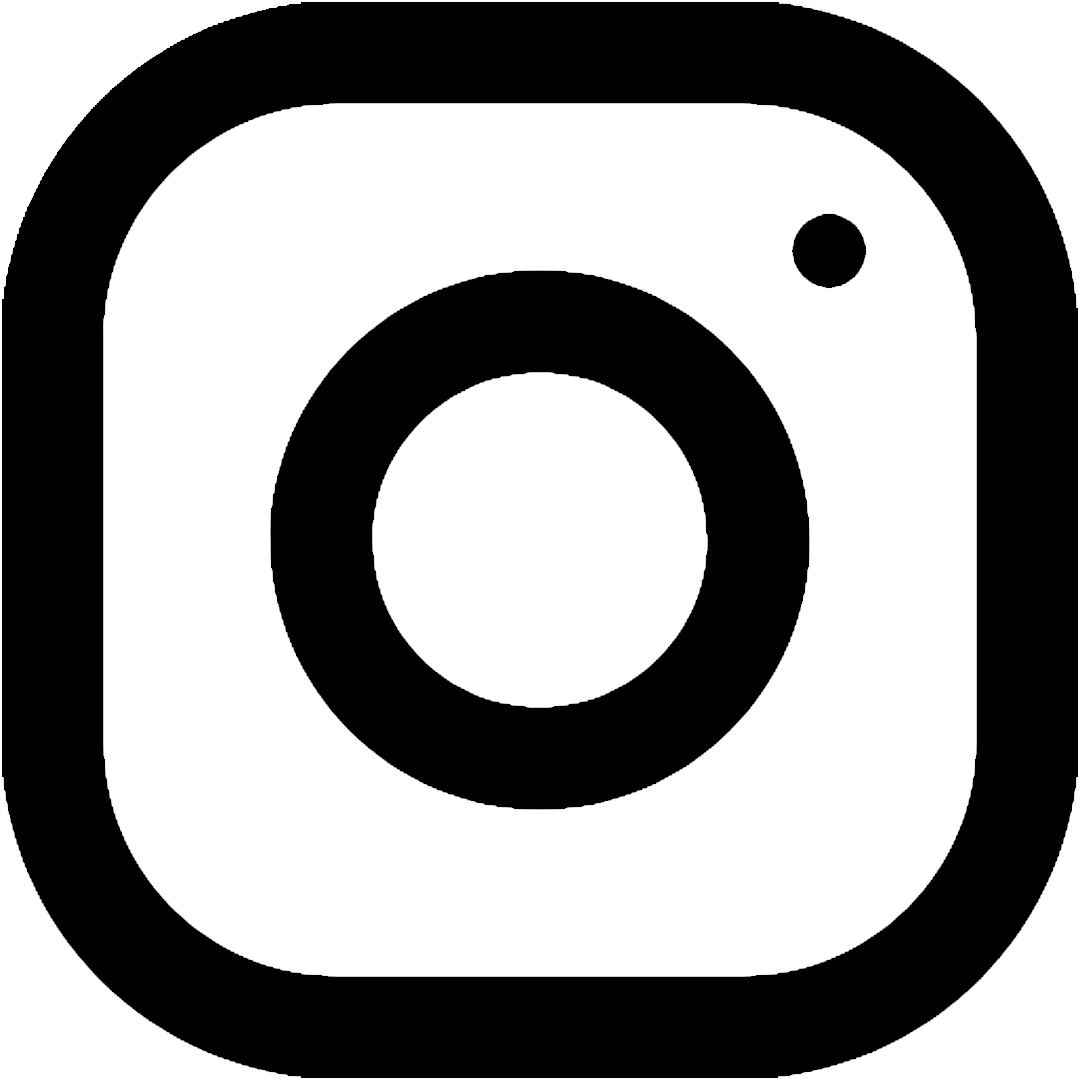@roommatesrock
Rock band from Ligurian west coast since 2012

join the room, become a mate!
Subscribe to our newsletter to be always updated on next live shows, new songs release and all the news about Roommates world!
Roommates - MUSIC VIDEO
roommates
- pistoia blues -

We've been sharing the stage as musicians since 2012, but Roommates are so much more than just a band. In these 10 years we have become a real family, taking our alternative rock with a strong emotional impact around Italy with the passion and energy that distinguish us, constantly searching for the emotion that comes from total involvement of the public that follows us and the one who discovers us for the first time.